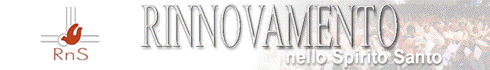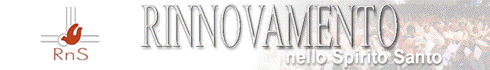|
Fede,
speranza e carità: le virtù del cristiano
Vita
del Rinnovamentoo
Gesù
(Tarcisio Mezzetti)
La
Quaresima, secondo il messaggio del Santo Padre, è il momento
favorevole per un itinerario che porti a «vivere in pienezza
la vita nuova in Cristo. Vita di fede, di speranza e di carità»
Le tre virtù che agganciano la vita umana al mistero di
Dio, sono state oggetto di approfondimento nel triennio di preparazione
al Grande Giubileo e ora devono essere vissute in modo “più
pieno e consapevole” da tutti i cristiani.
La
fede
Il
Vangelo, che è il fondamento delle verità cristiane,
è anche l’annuncio del regno di Dio e la proclamazione
della sua presenza nel mondo, tra gli uomini.
Ma
cosa significa la presenza di Dio nel mondo? Significa il capovolgimento
di tutto ciò che l’uomo crede, valuta e considera.
Dato poi che tutto esiste o diviene nello spazio e nel tempo,
il capovolgimento di tutto costituisce anche il capovolgimento
del modo di vedere lo spazio ed il tempo, cioè le coordinate
entro le quali si compie tutto ciò che è umano.
Sotto i presupposti di questo completo capovolgimento i "valori"
possono benissimo manifestarsi come disvalori, le "virtù"
come vizi, le "verità" come menzogne, i "successi"
come insuccessi, le "fortune" come disgrazie, ecc.
Questo
non sorprende, perché in realtà, nel Vangelo sono
detti "beati" coloro che piangono e non coloro che sono
nella contentezza, i poveri e i perseguitati e non i ricchi ed
i forti, ecc. Accogliere pertanto la presenza di Dio o del suo
regno, reca con sé la grande difficoltà di collocare
l’uomo in un nuovo spazio e in un nuovo tempo: lo spazio
e il tempo creati dalla presenza del Dio trascendente ed eterno
dentro il mondo limitato e provvisorio, entro lo spazio e il tempo
della conversione e della trasfigurazione dell’uomo. A questo
forse siamo chiamati in modo più insistente in questo anno
giubilare che celebra duemila anni dell’Incarnazione.
È
in questo nuovo spazio e questo nuovo tempo che si incontrano
esperienze di genere nuovo: le esperienze spirituali; quelle esperienze
che l’uomo fa nell’ambito di quello spazio e di quel
tempo trasfigurati, che la presenza di Dio nel mondo crea. Per
comprendere meglio questo concetto è utile esaminare la
domanda rivolta da Gesù ai suoi discepoli: «La
gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?» (Mt
16, 13).
Le
risposte a questa domanda possono essere così classificate:
- alcuni
vedono Gesù come profeta,
- altri
— come sappiamo da diversi testi evangelici — lo ritengono
indemoniato: «Gli risposero i Giudei: “Non
diciamo con ragione noi che sei un Samaritano ed hai un demonio?"»
(Gv 8, 48);
- Pietro
e gli altri discepoli, invece, lo riconoscono come: «Figlio
del Dio vivente».
Se
analizziamo le tre risposte dal punto di vista delle prospettive
spazio-temporali che presuppongono, si può osservare:
.
- Nel
primo caso, quando Gesù Cristo è riconosciuto
come profeta, l’uomo accoglie sì Gesù come
messaggero della divina volontà, ma rimane ancora prigioniero
delle sue limitazioni spazio-temporali. Gesù è
portavoce di Dio, ma non è Dio. La percezione
della reale presenza di Dio nel mondo è inesistente.
Si riconosce la realtà divina, la comunicazione con il
trascendente, ma non l’inserimento in essa.
- La seconda posizione, che ritiene Gesù "indemoniato",
ha anch’essa una dimensione religiosa, ma di carattere
demoniaco. I "segni" attraverso i quali Gesù
Cristo rivelava la sua divinità non sono visti come indizi
della presenza di Dio nel mondo o della sua comunione con l’uomo,
ma solo come atti soprannaturali straordinari. Anche in questo
caso vengono conservate le dimensioni umane dello spazio e del
tempo e Gesù non è riconosciuto come proveniente
da Dio, ma ritenuto strumento del diavolo. Si riconosce una
realtà trascendente, ma è una realtà che
non trasfigura il mondo presente.
-
La terza confessione, che Gesù è: «…il
Cristo, il Figlio del Dio vivente», presuppone invece,
l’accoglimento di nuove dimensioni spaziali o temporali,
ovvero l’inserimento dell’uomo in esse. Perché
l’uomo Gesù sia Figlio del Dio trascendente, perché
cioè sia possibile la presenza di Dio nella storia, devono
capovolgersi le concezioni dell’uomo riguardo allo spazio
e al tempo. L’accoglimento della presenza del trascendente
e dell’eterno nello spazio e nel tempo, suppone il cambiamento
totale delle coordinate razionali, ovvero, l’ingresso in
un nuovo spazio e in un nuovo tempo: conseguentemente, suppone
la rivelazione di Dio. Solo se Dio si manifesta all’uomo,
l’uomo può accettare Gesù Cristo come Dio.
Questa verità è espressa spesso e in vario modo
nella Prima Lettera di Giovanni, ove si legge tra l’altro:
»Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è
nato da Dio» (1 Gv 5, 1).
.
Ciò
significa che non è possibile per l’uomo credere che
Gesù è il Cristo, cioè uomo-Dio, se non è
Dio stesso che lo introduce nella nuova realtà, nella realtà
trasfigurata da Dio. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica:
«Con la fede l’uomo sottomette pienamente a Dio la
propria intelligenza e la propria volontà. Con tutto il
suo essere l’uomo dà il proprio assenso a Dio rivelatore.
La Sacra Scrittura chiama "obbedienza della fede" questa
risposta dell’uomo a Dio che rivela» (143).
Riscoprire
la dimensione trascendente della fede del credente, riportando
la fede al gesto di «assenso al Dio rivelatore»,
credo che debba diventare l’impegno della vita e della catechesi
in questo speciale anno Duemila, che ci ricorda in modo speciale
lo straordinario evento del Dio trascendente che entra nella storia
dell’uomo incarnandosi.
.
La
carità
Gregorio
di Nissa osserva che la virtù della pietà ha due
aspetti; quello delle verità della fede e quello etico.
Né le verità di fede senza l’etica né
l’etica senza le verità della fede, possono costituire
il tutto della pietà cristiana.
Tale
situazione si manifesta innanzitutto, attraverso il cosiddetto
materialismo pratico, che provoca una vera scissione nella vita
dei fedeli. La fede, non è più la regola della vita
quotidiana del cristiano; come spazio è limitata ai luoghi
sacri nei quali si va per rendere culto a Dio e nel tempo agli
attimi della comunicazione con Dio. In questo modo Dio è
stato sostanzialmente emarginato dalla vita dell’uomo ed
è stato trasformato in un elemento decorativo al servizio
di diverse esigenze, psicologiche, sociali o di altro tipo.
Una
seconda conseguenza negativa della rottura tra etica e fede è
il distacco dell’amore dal vissuto religioso. Le opere della
fede, ovvero i frutti dell’amore cristiano, vengono visti
indipendentemente dalla fede e dall’amore verso Dio e il
prossimo, in uno spirito puramente utilitaristico. Così
si coltiva il cosiddetto cristianesimo pratico o sociale, che
è sostanzialmente indifferente nei confronti della dimensione
trascendente del cristianesimo, anzi lo trasforma in religione
sociale e ricerca solo la valorizzazione delle sue dottrine etiche
e sociali. Questi due fenomeni patologici, il materialismo pratico
e il cristianesimo pratico o sociale, che per altro presentano
grande parentela fra loro, vengono ad essere in piena antitesi
con la tradizione e la dottrina cristiana e sono fonte di grandi
pericoli per la vita spirituale dei fedeli.
La
carità è quindi strettamente ed indissolubilmente
legata alla fede. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica:
«Al di sopra di tutto la carità — … è
opportuno ricordare il seguente principio pastorale enunciato
dal Catechismo Romano: "Tutta la sostanza della
dottrina e dell'insegnamento deve essere orientata alla carità
che non avrà mai fine. Infatti sia che si espongano le
verità della fede o i motivi della speranza o i doveri
della attività morale, sempre e in tutto va dato rilievo
all'amore di nostro Signore, così da far comprendere
che ogni esercizio di perfetta virtù cristiana non può
scaturire se non dall'amore, come nell'amore ha d'altronde il
suo ultimo fine"» (25).
Il
cristiano è chiamato all’amore e l’amore è
qualcosa che investe tutta la vita e le azioni del credente, anche
la sua vita sociale, ma il credente è sempre cosciente
che questo amore viene da Dio, perché, come dice Giovanni:
«… Dio è amore [Agape]; chi sta nell’amore
dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv 4, 16).
L‘amore
cristiano quindi, sgorga sempre da quella eterna fontana che è
Dio, ne consegue che la carità è figlia della fede.
Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea questa
dipendenza:
«La vita della fede - La parte terza del catechismo presenta
il fine ultimo dell'uomo, creato ad immagine di Dio: la beatitudine
e le vie per giungervi: un agire retto e libero, con l'aiuto
della legge e della grazia di Dio…; un agire che realizza
il duplice comandamento della carità, esplicitato nei
dieci comandamenti di Dio…» (16).
Tutta
la vita del credente è quindi impregnata permanentemente
dell’amore stesso di Dio e non potrebbe essere diversamente,
perché la fede, la speranza e la carità sono virtù
donate da Dio e non possono essere separate tra loro. Giacomo
chiedeva ai credenti:
«Che
giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le
opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello
o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano
e uno di voi dice loro: "Andatevene in pace, riscaldatevi
e saziatevi", ma non date loro il necessario per il corpo,
che giova? Così anche la fede: se non ha le opere, è
morta in se stessa. Al contrario uno potrebbe dire: Tu hai la
fede ed io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, ed
io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che
c’è un Dio solo? Fai bene; anche i demòni lo
credono e tremano! Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede senza
le opere è senza calore? Abramo, nostro padre, non fu forse
giustificato per le opere, quando offrì Isacco, suo figlio,
sull’altare? Vedi che la fede cooperava con le opere di lui,
e che per le opere quella fede divenne perfetta e si compì
la Scrittura che dice: E Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato
a giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Vedete che l’uomo
viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla
fede» (Gc 2, 14-24).
Il
Rinnovamento che è costituito da fratelli e sorelle che hanno
fatto un’esperienza profonda della presenza di Dio nella loro
vita, debbono, soprattutto in questo specialissimo anno giubilare,
tornare ad approfondire in modo specifico e convincente, il rapporto
indicibile e gioioso tra la fede e l’esercizio costante della
carità, che diventa così anche strumento particolare
della conversione del cuore. Il Rinnovamento, entra nella storia
del nostro tempo con lo stesso impeto con cui i grandi movimenti
monastici sono entrati nella vita della Chiesa attraverso i secoli,
e si manifesta quindi, all’occhio più attento, come
una vocazione ad un nuovo e più flessibile (forse più
difficile) monachesimo del nostro tempo. Ciò che il Catechismo
dice della vita religiosa potrebbe essere infatti facilmente adattato
al Rinnovamento nello Spirito:
«La vita religiosa sgorga dal mistero della Chiesa. È
un dono che la Chiesa riceve dal suo Signore e che essa offre
come uno stato di vita stabile al fedele chiamato da Dio nella
professione dei consigli. Così la Chiesa può manifestare
Cristo e insieme riconoscersi Sposa del Salvatore. Alla vita religiosa,
nelle sue molteplici forme, è chiesto di esprimere la carità
stessa di Dio, nel linguaggio del nostro tempo» (926) .
È
qui che si combatte la battaglia per la profonda conversione del
nostro cuore e dove il Rinnovamento si inserisce come parte prioritariamente
attiva, entro la spinta missionaria e caritativa della Chiesa.
La
speranza
Tra
le frasi più belle che Gesù ha detto, la seguente
ha assunto per me sempre
un grande valore: «Questa è la vita eterna: che
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato,
Gesù Cristo» (Gv 17, 3).
La
fede rappresenta quindi, l’inizio della vita eterna e noi
fin da ora possiamo gustare la gioia della fine del nostro pellegrinare
terreno, perché allora vedremo Dio, dice san Paolo: «…
a faccia a faccia…» (1 Cor 13, 12), e Giovani
afferma: «… così come egli è…»
(1 Gv 3, 2). San Basilio scrive:
«Fin
d’ora contempliamo come in uno specchio, quasi fossero
già presenti, le realtà meravigliose che ci riservano
le promesse e che, per fede, attendiamo di godere».
Tuttavia
queste cose le vediamo ancora in maniera confusa ed imperfetta,
le viviamo, infatti, solo nella fede. San Paolo direbbe: «…
camminiamo nella fede e non ancora in visione»
(2 Cor 5, 7).
Pur
avendo la luce luminosa della fede, a causa di colui in cui crede,
il credente vive quindi questa esperienza ancora nell’oscurità.
Il Catechismo insegna:
«…
La fede può essere messa alla prova. Il mondo nel quale
viviamo pare spesso molto lontano da ciò di cui la fede
ci dà la certezza; le esperienze del male e della sofferenza,
delle ingiustizie e della morte, sembrano contraddire la Buona
Novella, possono far vacillare la fede e diventare per essa
una tentazione» (164).
È
a questo punto che interviene in nostro aiuto la terza virtù:
la speranza. Di nuovo il Catechismo ci spiega la ragione
della speranza, la sua incessante, straordinaria, utilità
nei momenti di buio e di smarrimento:
«Allora dobbiamo volgerci verso i testimoni della fede:
Abramo, che credette "sperando contro ogni speranza"
(Rm 4, 18); la Vergine Maria che, nel "cammino della fede"6,
è giunta fino alla "notte della fede"7
partecipando alla sofferenza del suo Figlio e alla notte della
sua tomba; e molti altri testimoni della fede. "Circondati
da un così gran numero di testimoni, deposto tutto ciò
che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo
sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede"(Eb
12, 1-2)» (165).
Sembrerà
forse banale, ma è nell’approfondimento, nella meditazione
e nella riflessione costante sulle virtù teologali che
il Rinnovamento può ripartire per la più grande
evangelizzazione che investirà il terzo millennio dell’era
cristiana, forte dell’incoraggiamento del Papa che ci urge
a: «Varcare la soglia della speranza».
.
|