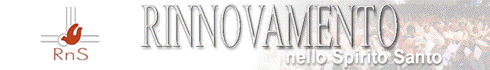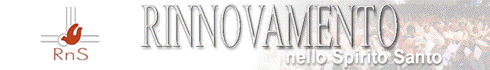La
nostra mentalità fatica a comprendere i salmi cosiddetti
“imprecatori” e una lettura superficiale ne allontana
un'autentica interpretazione. In realtà, essi sono espressione
di profonda avversione contro il male e l'ingiustizia e manifestano
il desiderio dell'intervento giusto di Dio.
«Acclamino
i hasidim nella gloria, facciano festa sui loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca, la spada a doppio taglio nella
loro mano per far vendetta tra i pagani, rappresaglie contro le
nazioni, per stringere in catene i loro re, i loro nobili in ceppi
di ferro, per eseguire contro di essi il giudizio già scritto:
questo è un onore per tutti i hasidim!» Così,
sul modello della «croce in una mano e della spada nell’altra»,
s’avanzavano cantando i hasidim, cioè "i
pii, i fedeli" ebrei durante la ribellione contro il re ellenista
di Siria, Antioco IV Epifane, ribellione ordita dai Maccabei,
tra i quali spiccava Giuda (seguito dai fratelli Gionata e Simone),
le cui gesta sono esaltate retoricamente ed epicamente nei due
libri dei Maccabei. «In quei giorni — si legge nel
primo di quei libri — ai Maccabei si unì il gruppo
degli Asidei (cioè i hasidim), eroi d’Israele,
tutti volontari della Legge» (cf 1 Mac 2, 42). Il canto
che abbiamo citato è riportato nel Salmo 149, ed è
probabilmente l’inno di battaglia e di fede di questi combattenti
del II secolo a.C. per la libertà religiosa e politica
d’Israele.
Presentati
come sacerdoti della guerra santa, i hasidim sono gli eredi
di una santa violenza che pervade non poche pagine dell’Antico
Testamento e che ha creato molte difficoltà, non solo alle
anime belle, ma alla stessa tradizione teologica cristiana, talora
tentata "ereticamente" di rimandare l’intero Antico
Testamento sotto l’egida di un Dio negativo e violento, dualisticamente
opposto al Dio cristiano dell’amore. I santi militari cantano
inni «sui loro giacigli», nelle notti d’attesa,
prima delle loro battaglie. E all’alba, eccoli, coi canti
d’Israele in bocca e con le mani che impugnano la micidiale
spada a doppio taglio. I cavalieri di Sion si scagliano nella
mischia, implacabili, scatenando rappresaglie, incatenando re
e generali, convinti dell’appoggio di Dio di cui eseguono
«il giudizio già scritto». Ma nella loro voce
sembra echeggiare un altro grido, quello degli Ebrei esuli di
quasi quattro secoli prima, che contro l’oppressore babilonese
scagliavano questa beatitudine sarcastica del massacratore: «Figlia
di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà il contraccambio
di quanto ci hai fatto! Beato chi afferrerà i tuoi piccoli
e li sfracellerà contro la pietra!» (cf Sal 137,
8-9). La furibonda imprecazione, formulata secondo la legge del
taglione, evoca una truculenta prassi orientale delle conquiste
militari: i bambini sfracellati contro i massi e lo sventramento
delle donne incinte volevano provocare, simbolicamente e concretamente,
la fine di un popolo nelle sue stesse radici.
Risalendo
lungo il fiume della storia biblica si può giungere sino
alla conquista della terra promessa, accompagnata da un cumulo
di sacre efferatezze: «Giosuè ordinò al popolo:
lanciate il grido di guerra perché il Signore consegna
in vostro potere la città di Gerico! Quanto è in
essa sia votato allo sterminio per il Signore… State lontani
da ciò che è votato allo sterminio e non prendete
nulla di ciò che è votato allo sterminio per non
rendere votato allo sterminio lo stesso accampamento d’Israele…
Votarono allo sterminio la città, passando a fil di spada
ogni essere ivi residente, dall’uomo alla donna, dal giovane
al vecchio, ma anche il bue e l’asino». Echeggia nel
racconto del libro di Giosuè (cf 6, 16-18.21), quasi come
in un lugubre ritornello, l’espressione «votare allo
sterminio», basata sul vocabolo herem (presente anche
nell’arabo harem, da noi usato) che di per sé indica
una realtà intangibile perché di proprietà
divina o superiore e, per traslato, una realtà da sacrificare,
da estinguere totalmente in un olocausto offerto al legittimo
proprietario, Dio, il condottiero nella guerra santa.
Oltre
la violenza ...
Questa
visione "militare" del Signore ha creato uno sconcerto
tale che ancor oggi il Concilio Vaticano II ha evitato l’uso
nella liturgia dei cosiddetti "Salmi imprecatori", carichi
di invettive e di fulmini: «Dio, spezza loro i denti in
bocca, rompi, Signore, le loro zanne da leone. Si dissolvano come
acqua e con essa si disperdano! Passino come la bava della lumaca
che si scioglie, come aborto di donna non vedano il sole. All’improvviso
li strappino via rovi spinosi o belve o incendio! Gioisca il giusto
nel vedere la vendetta, lavi i suoi piedi nel sangue degli empi!»
(cf Sal 58, 7-11; si veda anche il Salmo 109). Uno sconcerto che
evoca certi fantasmi, ad esempio il «Gott mis uns»
dei nazisti, quando si legge l’arcaico grido di guerra degli
ebrei nel libro dell’Esodo: «Jhwh è il nostro
vessillo di guerra» (Es 17, 15) e così via per tanti
altri passi anticotestamentari.
Come
giustificare il fatto che tante sante crudeltà e violenze
facciano parte di un libro sacro, considerato dai credenti ispirato
da Dio e «lampada per il loro passi» nel cammino della
vita? Molte giustificazioni delle guerre di religione si sono
basate su tali passi e i lettori fondamentalisti della Bibbia
devono o abbandonare la loro interpretazione "letteralista"
o allegramente dedicarsi a compiere stragi contro il nemico infedele,
cosa che non di rado fanno, limitandosi però oggi alla
violenza verbale. In realtà queste pagine meritano un’interpretazione
corretta che non le "schiodi" dalla propria storicità,
ma neppure le canonizzi automaticamente nel loro tenore immediato.
La via maestra per comprendere simili testi marziali e violenti
è ancora una volta quella di tener presente la qualità
strutturale ed essenziale della Rivelazione biblica: essa è
per eccellenza storica, cioè innestata nella trama faticosa
e tormentata della vicenda umana. Non è una parola sospesa
nei cieli e comunicabile solo estaticamente, ma è concepita
come un germe che si apre la strada sotto il terreno sordo e opaco
dell’esistenza terrena. La Bibbia si presenta come storia
progressiva d’una rivelazione progressiva del senso della
nostra storia apparentemente insensata o per lo meno convulsa
e confusa.
In
questo progetto generale della Scrittura le pagine violente sono
la rappresentazione di un Dio paradossalmente paziente che, adattandosi
alla brutalità e al limite dell’uomo, cerca di condurlo
verso un altro orizzonte. È per tale motivo che, accanto
al herem si trovano espressioni di compassione, di amore
e di apertura nei confronti dello straniero, fino a far balenare
un certo universalismo e a raggiungere un ideale di tolleranza:
«Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza, ci governi
con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al
tuo popolo che il giusto deve amare l’umanità»
(Sap 12, 18-19). Non bisogna poi ignorare un dato a prima vista
banale e scontato ma utile per un corretto ridimensionamento del
fenomeno bellico sacrale. Scriveva l’esegeta americano John
McKenzie nel suo Dizionario biblico: «I lettori moderni
considerano la concezione ebraica della guerra santa come un genere
primitivo di moralità: è vero, ma è anche
vero che tale concezione non era molto più primitiva della
concezione attuale della guerra».
Proprio
perché legate a coordinate storiche ben precise e a una
situazione socioculturale circoscritta, queste pagine violente
non devono essere assunte semplicisticamente col loro rivestimento
simbolico, ma devono essere "smitizzate" per isolare
alcuni valori ritenuti capitali da Israele. Pensiamo, ad esempio,
alla costante premura di salvaguardare la purezza della fede e
della propria identità religiosa. In una religiosità
simbolica la preoccupazione principale nel risparmiare qualcosa
alla distruzione militare non era legata a motivi umanitari, e
neppure a interessi economici immediati, quanto piuttosto a ragioni
che la Bibbia considera di lotta all’idolatria. Conquistare
gli idoli del popolo vinto significava allargare la propria sfera
di protezione divina e arricchire il pantheon del dio nazionale.
È per questo che si richiede la distruzione sacrificale
della preda di guerra: «Radunerai tutto il bottino e lo
brucerai nel fuoco come sacrificio per il Signore tuo Dio»
(Dt 13, 17). L’"anatema" o herem è
come un grande olocausto offerto a chi ha guidato Israele nella
vittoria: tutto dev’essere consumato dal fuoco e chi sottrae
qualcosa per idolatria o egoismo compie un sacrilegio. Certo,
è sempre una via primitiva e superabile per educare all’autenticità
e alla purezza religiosa, ma essa nasce, si svolge e si spiega
nell’ambito di una mentalità abituata al concreto,
al mondo dei simboli e legata a una particolare società
e cultura.
Questa
mentalità ben definita si esprime, tra l’altro, attraverso
un linguaggio che ama l’eccesso, l’esasperazione dei
toni, i colori accesi, l’uso di immagini barocche o surreali.
Il repertorio pittoresco di imprecazioni che intarsiano il Salmo
58 o il 109 va ricondotto e compreso all’interno del linguaggio
orientale che ama la sottolineatura, l’incisività,
l’impressionismo. È proprio sulla base di questa struttura
culturale che il male dev’essere sempre incarnato in un avversario
concreto, anche quando è un’entità sociale
o metafisica. Detto in altri termini, l’odio per il male
e l’ansia per la giustizia si manifestano pienamente scagliandosi
contro nemici rappresentati come vivi e concreti, ossia personificati.
I
Salmi imprecatori esprimono la loro passione per il bene e il
loro schierarsi per la giustizia attaccando un male personificato
nei "nemici", un’esigenza, questa, dettata dalla
propensione semitica alla concretezza e non all’idealizzazione.
La stessa concezione di Dio come generale supremo, che offre al
suo popolo quasi su un vassoio le città conquistate, è
una modalità simbolica per indicarne la personalità.
Dio non è un’energia cosmica misteriosa, non è
un’entità vaga o un essere mitico, ma per la Bibbia
è una persona che agisce, che entra nella storia, che si
schiera, opera, interviene, rivelandosi dotata di passione e volontà,
di comprensione e amore. L’idea dell’anatema o herem
ci conduce, quindi, a un’immagine divina personale, morale,
vivente, anche se la via adottata per disegnarla è ai nostri
occhi fastidiosa e faticosa da accettare.